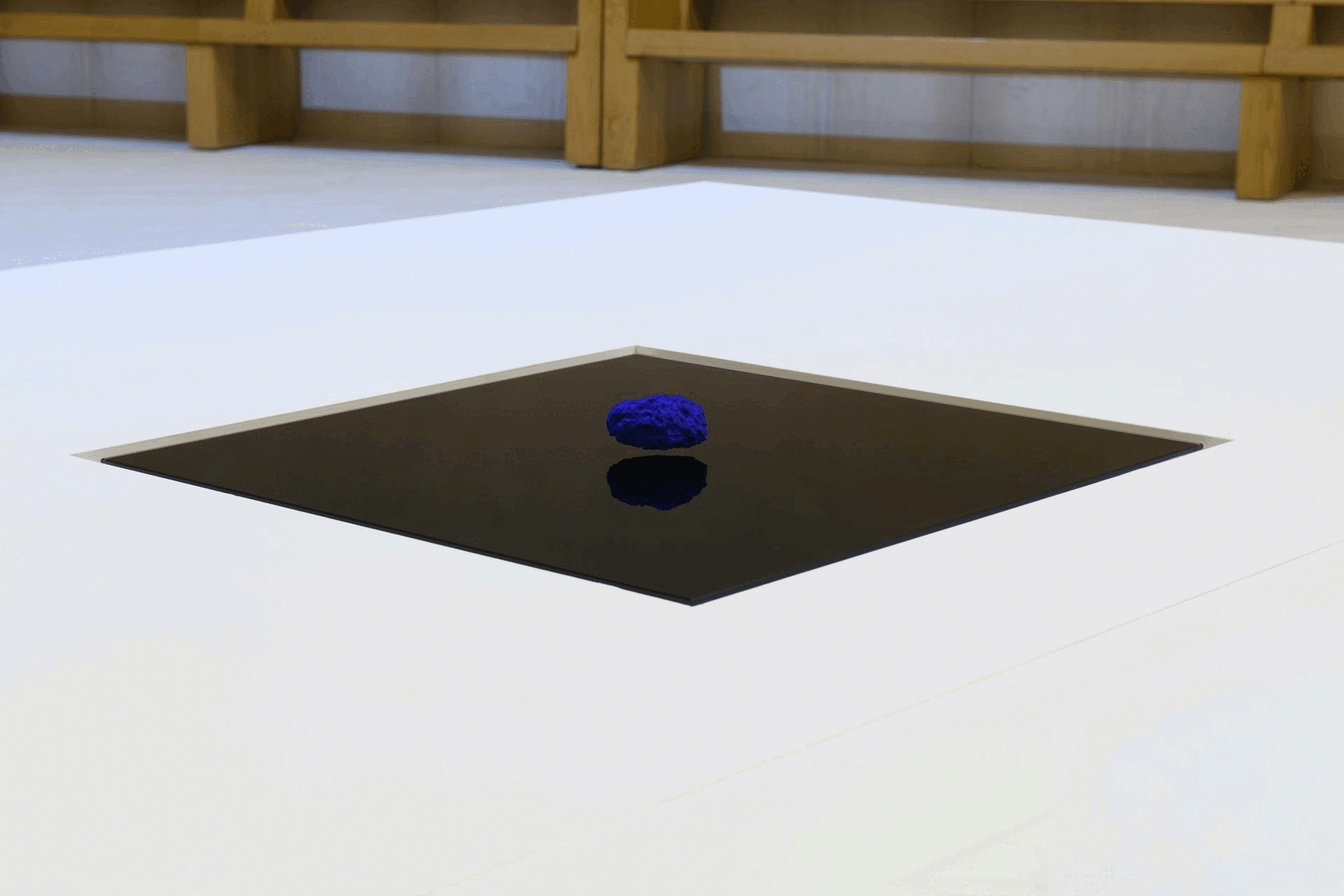EDITORIALE
La terra umida ha un odore fresco, vagamente pungente. Se vi è capitato mai di camminare in un bosco la mattina presto o di percorrere a piedi una vecchia galleria, il ricordo olfattivo di certo è connesso a quello epidermico del freddo, non necessariamente disturbante ma presente, caratteristico. Di certo si prova anche questo attraversando un’installazione di Delcy Morelos (Tierralta, Colombia – 1967), come Madre, opera monumentale composta da una mescola di terra, argilla, acqua, legno, metallo, iuta, fieno, paglia, cannella, chiodi di garofano, grano saraceno, semi di chia, tabacco e miele, che fino a gennaio 2026 abita gli spazi dell’Hamburger Bahnhof di Berlino, o come El Abrazo (2023), gigantesca ziggurat realizzata con il terriccio proveniente dai giardini pensili di Manhattan e migliaia di ciuffi di fieno inseriti a mano, che per tutta l’estate è stata esposta al Dia Chelsea di New York. Delcy Morelos vuole che ricordiamo. Le sue opere sono una porta emozionale su ciò che ci lega in modo ancestrale alle origini, ai sapori dell’infanzia, agli odori della casa, al contatto dei piedi con il suolo. "Tutto quello che esiste proviene dalla Terra e tutta la Terra rientra sempre in sé stessa – dice l’artista –. Il ferro che dà il colore rosso alla Terra è lo stesso ferro che rende rosso anche il nostro sangue." Anche la plastica, i mattoni, il cemento, il vetro vengono dalla terra, tutto è fatto (in forme diverse) di terra: l’artista celebra questo fatto incredibile (perché non ci pensiamo), riportandoci lì dove non siamo più abituati a stare, facendoci respirare e riconnettere con la materia da cui tutto ha avuto origine, e di cui troppo spesso non abbiamo alcuna cura. "Quello che a me interessa maggiormente, in questo momento, è parlare della cura che dobbiamo avere per la Terra e per gli altri esseri umani, che sono anch’essi Terra."
In questa duecentosessantottesima edizione di TELESCOPE, la nostra newsletter settimanale dedicata alle istituzioni e ai progetti culturali di cui siamo portavoce, tra i RACCONTI trovate un estratto da un testo della curatrice Chiara Parisi pubblicato su Esquire Italia e dedicato a Panorama Pozzuoli, nuova edizione della mostra diffusa promossa dal consorzio ITALICS; l’intervista della curatrice Fabiola Naldi al graffiti writer Kool Koor, tra i protagonisti della mostra HOPE AROUND. New York Graffiti al Foro Boario di Oristano; il testo critico di Cristina Maiorano curatrice della mostra Blu. I Fondamenti dello Spirito a San Giovanni Rotondo (FG). Nella sezione VIDEO proponiamo quello dedicato alla mostra di Albano Morandi. Il teatro delle cose minime al museo Mirad’Or, di Pisogne e uno sulla Nomadic School di OHT Office for a Human Theatre protagonista di un incontro alla Fondazione Benetton di Treviso. Gli EXTRA comprendono la 24° edizione del Premio Fondazione Mimmo Rotella; l'inaugurazione di BAAB Basement Art Assembly Biennial a Roma; e la presentazione del libro Le buone ombre di Irene Fenara al MACTE – Museo d’Arte Contemporanea di Termoli. In questo numero anche un BONUS TRACK dedicato alla nuova puntata di Radio GAMeC 30 che vede protagonista l’artista Tabita Rezaire.
Buona lettura! Lo staff di Lara Facco P&C #TeamLara
Vi ricordiamo che l’archivio di tutte le edizioni di TELESCOPE è disponibile su www.larafacco.com
TELESCOPE. Racconti da lontano Ideato e diretto da Lara Facco Editoriale e testi a cura di Annalisa Inzana Ricerca ed editing: Stefania Arcari, Camilla Capponi, Alberto Fabbiano, Andrea Gardenghi, Marianita Santarossa, Ludovica Solari, Denise Solenghi, Margherita Villani, con la collaborazione di Francesca Ogliari e Angelo Altamura, Rachele Caretta, Rossella De Toma, Giulia Maggi, Lucio Serena, Mariavittoria Stevan.
domenica 7 settembre 2025 RACCONTI
Il culto del divino. Panorama Pozzuoli, di Chiara Parisi*
Fra solfatare fumanti e rovine imperiali scorre la memoria di un potere che volle farsi dio: l’apoteosi degli imperatori romani, i prodigi di san Gennaro, le apparizioni popolari che ancora attraversano la cronaca partenopea. Non stupisce che Panorama Pozzuoli – quinta tappa del progetto ITALICS, dal 10 al 14 settembre 2025 – scelga proprio il “culto del divino” come bussola di un itinerario diffuso tra anfiteatri, ipogei e terrazze sul golfo. Il passato costruiva statue agli dèi. Il presente produce idoli a ciclo continuo. La divinizzazione si è fatta tascabile: abita lo schermo di un telefono, si misura in like, vende la merce della personalità come salvezza istantanea. È l’egemonia degli ego traboccanti, capi, creativi, figure pubbliche, che occupano la scena e sovrastano la conversazione. Ogni algoritmo scolpisce un piedistallo invisibile che si crepa in diretta. Hannah Arendt ci ricorda che il potere autentico nasce tra le persone, nello spazio condiviso dell’agire e del parlare, non nell’adorazione solitaria di un monologo. Se oggi celebriamo il singolo fino alla divinità, smarriamo quella pluralità che rende il mondo abitabile. Panorama Pozzuoli non propone nuovi santi né nuove icone, ma uno spazio fragile e concreto in cui l’arte apre una domanda: che cosa resta del sacro quando il culto è dappertutto? La vera soglia verso il divino, suggeriscono le strade della città-cratere, non è l’altitudine di un potere isolato, bensì la profondità di una presenza reciproca. La lava raffreddata di Pozzuoli ricorda che ogni innalzamento è provvisorio: un respiro della terra può far crollare colonne e narrazioni. Forse è tempo di convertire la nostra nostalgia d’infinito in responsabilità, sostituendo il culto della celebrità con l’arte di restituire dignità all’ordinario. In questa pagina di paesaggio, Panorama diventa l’occasione per una riflessione condivisa: se nessuno più merita d’essere divinizzato, chi, o che cosa, ha ancora diritto alla nostra venerazione? La risposta, a Pozzuoli, risuona come un’eco tra le fumarole: il mondo stesso, nella sua fragile e irripetibile pluralità. Solo così, abbattendo piedistalli per costruire luoghi d’incontro, potremo forse restituire futuro allo spazio comune che condividiamo. Pozzuoli è perfetta per parlare di divinità, di metamorfosi, di quelle cose che vanno su e poi giù, come gli dèi, gli artisti e i titoli in borsa. Qui il sacro non cade dall’alto: ribolle dal basso. Mettere l’arte in un luogo che trema è un modo onesto per capire se è viva.
*Estratto dal testo pubblicato sul numero 43 di Esquire di settembre 2025, dedicato a Panorama Pozzuoli, mostra diffusa a cura di Chiara Parisi, organizzata a Pozzuoli dal 10 al 14 settembre 2025, da ITALICS rete istituzionale che riunisce 70 gallerie di arte antica, moderna e contemporanea.
Crediti: Ph. Luciano Romano
Intervista a Kool Koor, di Fabiola Naldi*
FN. La prima domanda riguarda i tuoi inizi come graffiti writer: com'è cominciato tutto? Puoi raccontarmi del tuo rapporto con gli altri writer che già dipingevano in città? KK. All'inizio il mio primo contatto è stato con persone che vivevano nel mio palazzo e nel mio quartiere. Ogni giorno era una nuova scoperta, e ci sono voluti alcuni anni prima che riuscissi a capire davvero cosa stesse succedendo intorno a me. Era davvero incredibile rendersi conto che i nomi che vedevo scritti sui muri appartenevano in realtà a persone che conoscevo nel vicinato. La vera svolta è arrivata quando ho iniziato il liceo, nel 1978. È lì che ho conosciuto diversi graffiti writer provenienti da tutta la città. Quello è stato il mio primo "pass ufficiale" per muovermi in altri quartieri e realizzare graffiti insieme ad altri writer. FN. In che modo l’avvento del tagging e la nascita del graffiti writing nella cultura urbana hanno ridefinito il rapporto dell’individuo con lo spazio pubblico, trasformando muri urbani, treni e superfici in potenti piattaforme di identità, visibilità e autoaffermazione? KK. I muri e le superfici di New York sono diventati le nostre tele bianche. Mi sentivo libero, liberato: è stato un momento davvero ispiratore della mia vita. Ma è stato anche un periodo molto pericoloso, perché dovevi imparare in fretta come sopravvivere per strada. FN. Come si è evoluto il tuo stile di lettering in relazione alle superfici o tele su cui lavori, e in che modo queste caratteristiche fisiche influenzano le tue scelte formali e compositive? KK. I miei stili di lettering non si sono evoluti necessariamente in funzione delle superfici su cui disegnavo e dipingevo, era più un percorso personale, qualcosa che ho sviluppato passo dopo passo nel corso degli anni. Le mie scelte compositive erano – e sono tuttora – molto spontanee e organiche. Analizzo la superficie da dipingere e cerco di svuotare la mente il più possibile, lasciando che le idee arrivino naturalmente. La prima linea conduce alla seconda, poi alla terza e, prima che me ne renda conto, ho un intero outline tracciato. Da lì inizio ad aggiungere i colori, e infine i dettagli. FN. Quali sono gli elementi distintivi del tuo stile? Cosa ti attrae di temi come il futuro, l’architettura e lo spazio? KK. Gli elementi che definiscono il mio stile sono linee organiche, fluide, che sembrano labirinti e si muovono come alghe danzanti sotto la corrente di un fiume. Queste forme derivano dalle rappresentazioni architettoniche di città che disegnavo nei miei primi lavori, spesso situate sotto cupole geodetiche o piramidi. Se le osservi bene, puoi riconoscere quegli elementi anche nelle mie interpretazioni astratte delle città nei miei primi dipinti e disegni. Quindi sì, l’architettura è sempre stata molto importante per me. Ne sono sempre stato affascinato. Mi piace l’idea di progettare qualcosa che poi possa davvero esistere. Da bambino mi ritrovavo a disegnare città futuristiche e a immaginarle esistere fisicamente da qualche parte. Per me, quei dipinti e disegni non erano fantascienza. Erano scienza, in realtà. Non c’era nulla di fittizio. Per me, quelle cose esistevano davvero in un’altra dimensione. FN. Nel corso degli anni, quali tecniche hai esplorato e come si è evoluto il tuo stile attraverso diversi media? In che modo elementi come le dimensioni della tela, la disposizione dei pannelli o le combinazioni di colori hanno influenzato questa evoluzione? KK. Ho sempre cercato di spingere me stesso fuori dalla mia zona di comfort per provare qualcosa di nuovo. Questo mi ha portato a dipingere praticamente su qualsiasi superficie mi capitasse: vetro, metallo, plastica, carta, tela, ecc. Si potrebbe dire che è stata una sorta di esplorazione spaziale personale – non nello spazio esterno, ma dentro me stesso, cercando di scoprire cosa potevo fare di nuovo. Ho sempre voluto creare qualcosa di diverso, di significativo e, soprattutto, qualcosa che non fosse come quello che facevano gli altri.
*Intervista realizzata in occasione della mostra HOPE AROUND. New York Graffiti a cura di Fabiola Naldi, promossa da DROMOS FESTIVAL, che fino al 25 ottobre è ospitata negli spazi del Foro Boario di Oristano.
Crediti: DROMOS FESTIVAL, HOPE AROUND. New York Graffiti, Installation view, 2025. Ph.Francesco de Faveri
Blu. I Fondamenti dello Spirito, di Cristina Maiorano*
La mostra Blu. I Fondamenti dello Spirito, organizzata dal Comune di San Giovanni Rotondo in occasione del Giubileo 2025, è un pellegrinaggio diffuso tra il Santuario di San Pio e tre chiese del borgo antico — San Nicola, San Leonardo Abate e San Giovanni Battista — che intreccia l’eredità visionaria di Yves Klein con le ricerche di artisti contemporanei. Non un semplice itinerario espositivo, ma un cammino nell’arte e nello spirito: ogni chiesa diventa una soglia, ogni opera un varco verso l’invisibile. Al cuore del percorso, nel foyer del Santuario di San Pio, sono presentati gli ex-voto di Klein, tra cui il Monocromo blu proveniente dal Monastero di Santa Rita a Cascia (in prestito dopo la mostra Per Grazia Ricevuta a Napoli). Accanto, le celebri Tables Monogold, Monopink e Monoblue e La Terre Bleue restituiscono la dimensione votiva e contemplativa della sua ricerca: oro, rosa e blu come corpo, anima e spirito; pigmenti puri come materia immateriale; un globo trasfigurato in sfera cosmica. Qui il colore non è superficie ma soglia, presenza viva, preghiera laica che si offre al cielo. In dialogo, le opere di Luca Pozzi attivano nuove risonanze: una spugna blu sospesa nel vuoto da un campo magnetico, altare contemporaneo che fluttua tra visibile e invisibile; e uno specchio “cosmico” che decodifica segnali subatomici in tempo reale, trasformando la scienza in oracolo e aprendo al visitatore l’esperienza di un contatto con l’insondabile. Nel borgo antico, le altre chiese diventano tappe di un pellegrinaggio interiore. Francesco Fossati, a San Nicola, abita gli spazi con volumi essenziali che si proiettano idealmente in una dimensione post-umana di riappropriazione da parte della natura di spazi e materiali. Vincenzo Marsiglia, a San Leonardo, trasfigura la facciata della chiesa con Evolution: un rosone di luce in neon blu che unisce architettura e simbolo, spirito e materia, richiamando la Trinità e l’infinito. Penzo+Fiore, nella Rotonda di San Giovanni Battista, propongono E sia: un’infiorata di vetro muranese, centinaia di fiori custoditi in ampolle trasparenti, fragili e insieme incorruttibili. Sabbia dell’Adriatico, voci e suoni trasformano lo spazio in un luogo di raccoglimento e comunità, dove la fragilità si rivela forza luminosa. Blu. I Fondamenti dello Spirito è un cammino che unisce devozione e ricerca, memoria e innovazione, arte e vita. È un invito a sostare e ad attraversare: perché l’abisso blu di Klein e le risonanze contemporanee non chiedono risposte immediate, ma aprono spazi di contemplazione. Un pellegrinaggio nel pellegrinaggio, che riconsegna al visitatore l’esperienza di un fondamento spirituale rinnovato, fragile e luminoso come il vetro, potente e infinito come il blu.
*Testo redatto per la mostra Blu. I Fondamenti dello Spirito in corso fino al 30 novembre 2025 al Santuario di San Pio da Pietralcina e nelle chiese di San Nicola, San Leonardo Abate e San Giovanni Battista a San Giovanni Rotondo (FG).
Crediti: Blu. I Fondamenti dello Spirito, installation view. Ph. Mirco Migliocca VIDEO
 Una mostra sul lago
Fino al 14 settembre sul Lago d’Iseo, a Pisogne, la mostra Il teatro delle cose minime accoglie in tre luoghi simbolici del territorio – Museo Mirad’Or, Chiesa di S. Maria della Neve e Torre del Vescovo – le opere ambientali di Albano Morandi, artista e regista di Meccaniche della Meraviglia, progetto che da oltre vent'anni coniuga l'arte contemporanea al territorio della provincia di Brescia. Con questa esposizione prende il via il nuovo corso del museo Mirad’Or, promosso dal Comune di Pisogne e affidato alla direzione scientifica di Flaminio Gualdoni e a quella artistica di Marco Lagorio. Il progetto, composto da tre installazioni site-specific, vuole essere una narrazione unitaria, che intreccia arte contemporanea, memoria storica, spiritualità popolare e paesaggio. In questo video l’artista cci conduce alla scoperta del suo lavoro e della bellezza dei luoghi che lo ospitano.
Crediti: Mirad'Or, Albano Morandi. Ph. Alice Consoli  Un progetto di pedagogia alternativa
Venerdì 12 settembre, Filippo Andreatta è protagonista del primo incontro di Naturale Inclinazione 2025 | Abitare la montagna, ciclo promosso da Fondazione Benetton dedicato alla cultura del giardino nel mondo contemporaneo. Nell’ambito di questa edizione, dedicata alla montagna come luogo privilegiato di relazione tra uomo e natura, spazio di esplorazione e contemplazione e anche ambiente fragile minacciato dalla crisi climatica, Filippo Andreatta (regista e fondatore di OHT) e il curatore Edoardo Lazzari si confrontano nell’incontro dal titolo La Scuola Nomadica. Un progetto di pedagogia alternativa di Office for a Human Theatre nei territori alpini. In questo video un racconto suggestivo dell’esperienza della Scuola Nomadica realizzata dall’8 al 20 giugno 2025 da OHT in Val d’Agola sulle Dolomiti di Brenta e da cui prende spunto l’incontro.
Crediti: Nomadic School 2023. Credits Giacomo Bianco EXTRA
 Paolo Sorrentino vince il Premio Fondazione Mimmo Rotella
Dopo essere stato assegnato ad attori, registi, artisti del calibro di Al Pacino, Michael Caine, Ai Weiwei, Willem Dafoe, Julian Schnabel, Hayao Miyazaki e Shirin Neshat, è il regista napoletano Paolo Sorrentino il vincitore della 24° edizione del Premio Fondazione Mimmo Rotella evento collaterale della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Il regista è stato premiato venerdì 5 settembre, alla presenza del presidente della Fondazione Nicola Canal e del direttore artistico del Premio Gianvito Casadonte, nel giardino della Peggy Guggenheim Collection di Venezia. Istituito nel 2001 per volontà dell’artista, il Premio è dedicato alla relazione tra cinema e arti visive: un omaggio alla settima arte, fondamentale nell’immaginario e nella poetica di Rotella. “Ero sempre affascinato dal cinema – dichiarò Mimmo Rotella in un’intervista – e nel 1958 ho cominciato a usare i suoi manifesti per farne opere d’arte, con la tecnica del décollage. Le mie opere ispirate al cinema sono quelle che amo di più. Le ho cercato di realizzare con la stessa fantasia e libertà che trovavo nel cinema”.
Crediti: Gianvito Casadonte (Presidente Fondazione Premio Mimmo Rotella), Anton Giulio Grande (Presidente Calabria Film Commission), Paolo Sorrentino, Nicola Canal (Presidente Fondazione Mimmo Rotella). Ph. Pierpaolo Voci  Una Biennale per Roma
Con un’ampia selezione di media, interventi site-specific, installazioni, performance, film e nuove produzioni, dall’11 settembre al 6 novembre apre l’edizione di esordio di BAAB Basement Art Assembly Biennial. Ideata e curata da Ilaria Marotta e Andrea Baccin, direttori fondatori di CURA., con un Advisory Board composto da Nicolas Bourriaud, Jean-Max Colard, Simon Denny, Anthony Huberman e Lumi Tan, questa edizione pioniera si articola negli spazi di Basement Roma – spazio espositivo autosostenuto fondato nel 2012 da CURA. – e una serie di hotspots in città: un cinema, un teatro e manifesti pubblici. Accompagnano le opere di Davide Balula, James Bantone, Cecilia Bengolea, Hannah Black, Danielle Brathwaite-Shirley, Vittorio Brodmann, Claudia Comte, Jeremy Deller, Gina Fischli, Gina Folly, Calla Henkel/ Max Pitegoff, Carsten Höller, Karl Holmqvist, David Horvitz, Than Hussein Clark, Mark Leckey, Lily McMenamy, Nyala Moon, Valentin Noujaïm, Puppies Puppies (Jade Guanaro Kuriki-Olivo), Michele Rizzo, Selma Selman, Tobias Spichtig, Nora Turato, Women’s History Museum (Mattie Barringer/ Amanda McGowan), anche Sonorama - sezione “sonora” curata da Ruggero Pietromarchi - un esteso programma di letture, talk, performance e proiezioni, un performing program co-curato con Ilaria Mancia e un podcast a cura di Martha Kirszenbaum. Chiuderà la Biennale una cena sociale che coinvolgerà la comunità di artisti partecipanti in una cooking session.
Crediti: Than Hussein Clark, Monza 1925 - Foley Track, 2017. 16 speaker, sound, 20 Min 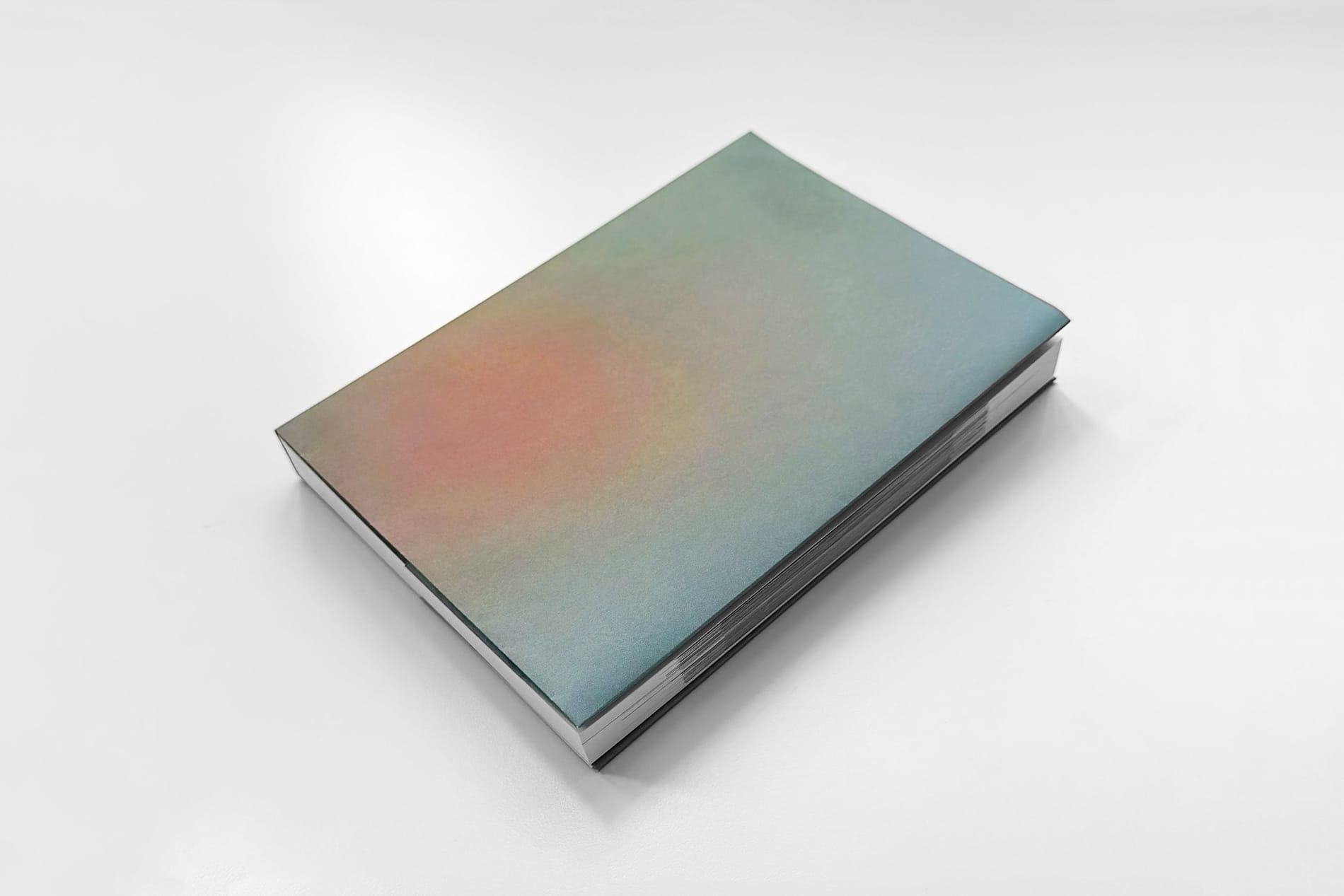 Al confine tra visibilità e invisibilità
Sabato 13 settembre alle ore 18.30-20 (ingresso libero) il Museo di Arte Contemporanea di Termoli ospita la presentazione del catalogo di Le buone ombre, mostra personale di Irene Fenara (Bologna, 1990) che si è tenuta negli spazi del museo da ottobre 2024 al gennaio 2025. Vincitrice del Premio mostra alla 63° edizione del Premio Termoli, Irene Fenara con la sua arte esplora il confine tra visibilità e invisibilità, natura e tecnologia, proponendo una riflessione sul ruolo delle immagini nell'era della sorveglianza. A un anno dalla mostra il libro, edito da Paint it Black, raccoglie una selezione ampia e rappresentativa delle immagini che costituiscono la sua ricerca, un capitolo visivo composto quasi esclusivamente da immagini, e un saggio di Caterina Riva. Durante la serata saranno disponibili all'acquisto delle copie del libro. BONUS TRACK
 Radio GAMeC 30 | 2024
Il 2024 è stato un anno che, tra eventi decisamente sismici e altri silenziosi, ha ridefinito le dinamiche globali. A livello economico il blocco BRICS si espande, accogliendo Etiopia, Egitto ed Emirati Arabi; le leadership mondiali subiscono cambiamenti in Gran Bretagna, Francia, Germania, Corea del Sud e Iran; in ottobre Israele invade il Libano per la sesta volta, lasciandosi dietro una scia di sangue; Donald Trump torna a essere eletto Presidente degli Stati Uniti mentre il regime di Assad crolla sotto la pressione interna e internazionale. Allo stesso tempo, il 2024 si è rivelato un anno devastante, segnato da disastri naturali e dal superamento della soglia di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, rendendolo l'anno più caldo degli ultimi 175 registrati. In questa puntata di Radio GAMeC 30 l'ospite è Tabita Rezaire, artista interdisciplinare, attivista e coltivatrice di cacao residente nella Guyana francese che durante la conversazione con la curatrice Alice Labor ha riflettuto sull'impatto ambientale legato al surriscaldamento climatico.
Sei un giornalista, un critico, un curatore? Vuoi contribuire con un tuo scritto a una delle prossime edizioni di TELESCOPE? Scrivici su telescope@larafacco.com
Se vuoi ricevere TELESCOPE anche tu, scrivi a telescope@larafacco.com
L'archivio completo di TELESCOPE è disponibile sul sito www.larafacco.com
Via della Moscova 18 · 20121 Milano press@larafacco.com www.larafacco.com
|